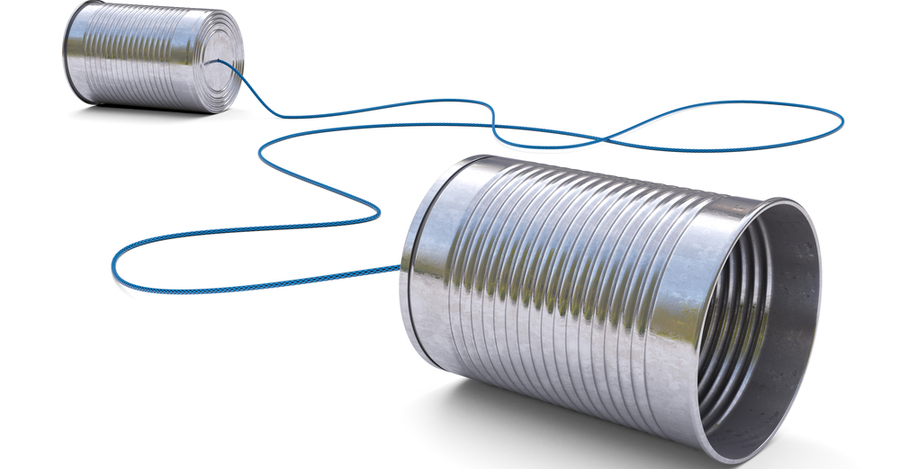Osservazioni introduttive
- Il nucleo del mio discorso è la finitudine dell’uomo, vista come Non Onnipotenza, che traduce a livello esistenziale e quotidiano, la realtà del morire.
- Per attualizzare questa intuizione la applico alla comunicazione in atto: la non onnipotenza si traduce nella impossibilità di comunicare totalmente quello che ho in mente e che sento. Accettare la morte come componente coassiale all’esistere significa rendersi conto di questa finitudine, sia da parte di che parla che di chi ascolta. Questa prospettiva ha una valenza psicologica, una valenza sociologica e una etica. Saranno i tre livelli del mio comunicare che tuttavia sa già di non poter essere esaustivo e di dire solo poche cose. Questo farà sì che la mia comunicazione sia viva proprio perché è solo la coscienza e il vissuto della finitudine. che permette la vivacità del pensare e la vivacità del comunicare. È infatti la stessa finitudine che fa sì che, non dicendo tutto io, si lascia spazio anche per chi vuole intervenire e dialogicamente esperimentare una comunicazione a più voci (G. Palo, 1999)
- Le mie riflessioni attingeranno a due tipi di fonti: una più spiccatamente teorica all’insegna delle discipline scientifiche testé citate e una più pratica che attinge il repertorio della mia esperienza psicoanalitica, soprattutto a livello di gruppi di operatori che lavorano negli ospedali e in genere nella sanità.La coniugazione delle due fonti sarà attivata soprattutto dalla riflessione etica che per sua natura unisce la teoria e la prassi, il logos e il mito in un tessuto vitale rappresentato dal quotidiano di ciascuno, a livello individuale e di gruppo.
A. Riflessione psicologica
Nei confronti della morte si attivano dal punto di vista psicologico una serie di difese che servono a prendere la distanza dall’ansia e dalla sofferenza che una tale realtà impone (A. Freud, 1953).
Le difese non sono meccanismi negativi, sono degli atteggiamenti che servono ad eliminare le ansie eccessive che non possono essere sempre in azione.
Nei confronti della morte, suprema verità antropologica, è comprensibile che le difese siano molto forti e arrivino anche alla negazione.
- La morte infatti viene spesso negata a livello individuale e a livello collettivo. I due livelli sono collegati e si intrecciano secondo dinamiche complesse e molto interessanti. Questo intreccio è alla base del mio intervento che oscilla tra il sociale e lo psichico. Il rito e il mito sono infatti dei fenomeni complessi che, attingendo al mondo della simbolizzazione, si pongono in posizione di frontiera tra lo psichico e il sociale.
La negazione della morte è collegata con la fantasia di onnipotenza, prepotentemente presente in ogni essere umano e in ogni cultura/istituzione. Sono onnipotente, sono Dio e come tale immortale. A me non tocca di morire, l’esperienza della morte è propria degli altri, non mia.
- Una seconda difesa è rappresentata da un atteggiamento che chiamo paranoico, collegato con la lotta, con la guerra di uno contro l’altro. La morte in questo caso deve essere combattuta con tutti i mezzi. L’aggancio con la prospettiva culturale è troppo evidente perché sia ulteriormente sviluppata. Noi ci troviamo fondamentalmente nel mito della tecnica, che è legato all’onnipotenza, nella dimensione della lotta al limite, che è pure legato all’onnipotenza, nella guerra senza frontiera nei confronti della morte non vista assolutamente come una «sorella» di francescana memoria. In questo clima tutto quello, che ci porta la morte deve essere combattuto e debellato. Il medico diventa il cavaliere della vita, mentre ogni agente che va contro a questa prospettiva, che intacca la vittoria sulla morte è da debellare o, quanto meno, da evitare (F. Fornari, 1966).
- C’è poi una terza difesa che è quella che chiamo depressiva. È connessa all’elaborazione del lutto, di cui ampiamente ci ha parlato il Prof. Alfonzo Di Nola in molte sue pubblicazioni che penso siano conosciute.
Per depressione non intendo quello che comunemente viene catalogato nel vocabolario psichiatrico tradizionale. Per depressione intendo la fase di rinuncia alla onnipotenza, la accettazione della propria finitudine e quindi della morte. La morte non è in questo caso, solo la morte fisica, estremo atto della resistenza, la morte è ogni traduzione del limite rivestito da mille vissuti che vanno dall’esperienza della propria imperfezione, alla prova della imperfezione degli altri, di quelli che amiamo soprattutto e di quelli che non amiamo molto.
B. Riflessione sociologica
Mi rifaccio soprattutto alla sociologia della conoscenza, una branchia molto interessante della scienza sociologica che tenta di far vedere la relazione esistente tra il modo di pensare di una epoca e la struttura sociale (G. Palo, 1979).
A me serve soprattutto la relazione esistente tra un particolare modo di difenderci nei confronti della morte e la sua simbolizzazione, cioè la ritualizzazione.
Ogni epoca ha infatti i suoi riti che non cadono dal cielo ma sono il frutto di quell’intreccio che richiamavo precedentemente tra lo psichico e il sociale.
Pensiamo a come una negazione pressoché totale della morte porti a una ritualizzazione del morire molto povera e scarna. Basti pensare ai funerali delle grandi città per rendersi conto del come funzioni il collegamento tra la negazione psicologica della morte e la scarna ritualizzazione.
Il pensare alla morte in un certo modo (o il non pensarci affatto), porta un’espressione simbolica del morire, a un rito (visto come un insieme di gesti altamente simbolici atti a tradurre una serie di sentimenti a livello collettivo) che traduce la stessa paura, la stessa difesa, la stessa non accettazione. Ma pensiamo anche alla ritualizzazione del morire nei nostri ospedali.
Senza generalizzare indebitamente, la omogeneità della cultura occidentale e la sovrabbondanza della valenza tecnologica, vista come mito dominante, fa sì che il morire non sia affatto ritualizzato. Diventi un evento ineliminabile che tuttavia non viene gestito con la necessaria serenità attinta a una accettazione della morte, vista come elemento importante del vivere. Per ulteriormente sviluppare, anche da un punto di vista maggiormente scientifico questa riflessione, vorrei rimandare ad alcuni meccanismi di simbolizzazione ritualizzante che possono servire poi per una dimensione progettuale diversa.
Berger, un sociologo della conoscenza di stampo americano, ha scritto un testo che ritengo fondamentale sulla costruzione sociale della realtà. Vi si sostiene che la società, il sapere, il pensiero e l’azione non cadono dall’alto ma hanno un preciso legame (P. Berger, 1995). Egli annuncia tre leggi:
- L’esteriorizzazione che consiste nella effusione permanente dell’essere uomo attraverso la sua attività fisica e mentale.
- L’obbiettivazione attraverso la quale i prodotti dell’attività umana diventano una realtà che si impone con le sue leggi e la sua struttura.
- L’interiorizzazione che costituirebbe il momento di appropriazione da parte dell’uomo della stessa realtà creata da lui o dai suoi simili, processo che fa subire all’uomo un’ulteriore modificazione.
Se noi applichiamo questo alla ritualizzazione della morte possiamo osservare come il momento della esteriorizzazione che presiede alla ritualizzazione dipenda dal modo di pensare e di vivere la morte.
Una società che vede la morte come nemica, che attua quindi, per stare allo schema precedentemente proposto, una difesa di tipo paranoide, cercherà di esteriorizzare il proprio modo di vedere le cose e di viverle. Il rito della morte si consumerà all’insegna di vincitori e di vinti, il morire sarà quasi un campo di battaglia in cui vari contendenti lottano sino all’ultimo sangue per sconfiggere la morte. Dal punto di vista culturale oggi si è addirittura coniato un termine per esprimere questo: l’accanimento terapeutico. Noi sappiamo che i neologismi sono un rito, un rito linguistico estremamente importante per fronteggiare la realtà. Una società meno paranoica e più riconciliata con il proprio limite ritualizzerà la morte non sotto il simbolo del campo di battaglia, ma con altri gesti. Quello che voglio sottolineare non è la dinamica dei vari riti o come fare a ritualizzare bene, vorrei spendere qualche parola per far notare come i vari rituali sono collegati a dei modi di pensare e come la modifica di questi imponga una nuova creatività; pena la scissione e la schizofrenia culturale.
Vorrei inoltre notare come lo schema precedentemente enunciato serva a far capire come una volta che un modo di pensare e di vivere la morte è stato ritualizzato, cioè è avvenuto il processo di oggettivizzazione, il rito acquista delle leggi sue proprie indipendentemente da chi l’ha prodotto, diventa viscoso, con uno spessore culturale molto forte. È solo la introduzione del terzo momento, quello della riappropriazione, che permetterà una eventuale modifica con la creazione di un nuovo rituale.
La metafora della goccia d’acqua
Per cercare di far capire maggiormente il mio pensiero ricorro a una metafora che mi è stata suggerita da un caro amico nonché illustre studioso di questi problemi, Raimundo Panikkar (R. Panikkar, 1981). Si può pensare alla vita/morte come a una «goccia d’acqua». Tutto dipende dall’accento che viene posto sulla goccia o sull’acqua. La cultura occidentale preferisce accentuare la goccia: abbiamo allora il fatto che quando l’acqua va nel mare, essendo goccia, si dissolve, muore sparisce. La morte, essendo la morte della goccia provoca la fine di tutto. Molto dipende dalla nostra brama di oggettivare che porta alla disumanizzazione.
Anche la morte è sottoposta a questo processo, ma la morte non è oggettivabile, nessuno che l’ha esperimentata ha potuto descriverla, la morte è la nostra verità, ma io credo che la verità è relazione e non assoluto. Su questa piattaforma è bene discutere e vedere di dialogare sapendo che nessuno sa cosa è veramente la morte, sa che è la modificazione di rapporti importanti, che cambia la nostra maniera di relazionarsi, sa che fa soffrire perché taglia, recide, ma sa anche che costituisce una certezza, la sola certezza che ci caratterizzi.
La cultura orientale pensa diversamente, predilige l’accentuazione dell’acqua. Abbiamo allora il fatto che quando l’acqua va nel mare (morte) essendo acqua e non solo goccia non tutto sparisce. L’acqua della goccia rimane, a sparire è solo la goccia. In questa metafora è racchiusa tutta una tradizione filosofica di grande portata. Non è vero che si tratta di strane elucubrazioni, si tratta invece di impostazioni di pensiero che investono la antropologia, cioè la maniera di sentirsi e di viversi; hanno una importanza enorme per i problemi che stiamo trattando, che non possono essere lasciati solo ad una riflessione tecnico-scientifica.
C. La riflessione etica
Ma, se è vero tutto questo, non è importante scoprire un nuovo modo per ritualizzare e morire che tenga presente varie possibilità, che non si appiattisca in una prospettiva puramente tecnica? La dimensione psicologica allora si coniuga con quella sociologica e diventa etica nel senso che controlla le scelte che un individuo, un gruppo, una istituzione, una cultura fanno. I riti sono inevitabili, quello che stiamo facendo adesso noi con questo incontro interessantissimo è anch’esso un rito con le sue lezioni, con le sue pause, con i suoi battimani e con i suoi silenzi. Si tratta di riflettere su queste cose per non lasciarci travolgere. Ho tentato, di dare un modello di lettura, un possibile percorso che aiutasse ciascuno nella difficile operazione di costruzione della propria vita e della propria morte assieme alla vita e alla morte di coloro che ci stanno vicini.
Le mie non volevano essere ricette, avevano la pretesa di essere degli strumenti da far lavorare nella vita di ciascuno, per dar vita a quella operazione di riappropriazione impossibile senza la presa di coscienza dei momenti di esteriorizzazione e di oggettivizzazione, ma impossibile anche senza una attitudine metaetica. Rimando alle pubblicazioni in cui ho ampiamente espresso la struttura dell’etica vista prevalentemente come un fatto.
Il primo elemento è costituito dall’ethos, il modo di fare abituale di un individuo o di un gruppo (G. Palo, 1979-1989)
L’ethos collegato al morire riguarda il modo pratico, concreto di comportarsi nei confronti della morte. In un contesto rituale, fortemente cristiano, l’ethos del morire è molto attivo e ancora abbastanza omogeneo, rimanda a tutta una serie di gesti sul morto, sui parenti, sulle istituzioni religiose che portano a dei simboli abbastanza precisi e codificati. Ma anche al di fuori di un contesto siffatto, la morte ha sempre con sé un ethos particolare che può variare da paese a paese, da ospedale a ospedale, ma che c’è.
L’etica è l’imperativo che potremmo definire più teorico, anche se non completamente tale, si traduce nel si deve fare in un certo modo. Non necessariamente è collegato coerentemente con l’ethos. Si verifica spesso il caso che l’ethos impone delle cose che l’etica individuale del soggetto non crede. Eppure in un clima di integrazione culturale l’ethos e la etica vanno abbastanza d’accordo.
La metaetica costituisce un terzo livello della struttura del fatto etico. Può essere una operazione sofisticata, propria degli analisti etici di professione, ma, a mio parere, è presente in qualsiasi soggetto umano che, in maniera intelligente, sia capace di riflettere sulla propria esistenza, sul suo modo di pensare e sul suo modo di agire. Applicare questo modello operativo al tema che stiamo trattando mi pare molto interessante perché permette di legare assieme vari aspetti che rischiano spesso di restare slegati tra di loro.
A mo’ di conclusione
Noi siamo nel mito della tecnica, su questo possiamo esser tutti; d’accordo. In questo mito la morte o è negata o occupa un posto secondario L’ethos abituale è di minimizzare la ritualizzazione, privatizzarla, sottrarla allo schermo del pubblico.
L’etica è quella della massima efficienza, del successo, della onnipotenza, piuttosto privatizzante e individualizzata, narcisistica. La riflessione metaetica permette di far breccia in questo universo coerente e dar vita alle maglie di libertà e di creatività altrimenti perdute.
Allora si impongono una serie di interrogativi come: ma quale uomo è sotteso a questa etica, ci piace, ..ci sembra realistica, che dinamiche promuove, perché è così?.. La morte è proprio una cosa solo da combattere, non fa parte della realtà umana per cui si comincia a morire quando si nasce, non è forse meglio avere un atteggiamento diverso?
QUESTE DOMANDE LE LASCIO ALLA RIFLESSIONI DI OGNUNO CHE PUÒ ESPRIMERE LE PROPRIE OSSERVAZIONI IN UN DIALOGO ETICAMENTE RILEVANTE O PUÒ TENERLE DENTRO DI SE, CON L’AUSPICIO CHE LO FACCIANO LAVORARE E STIMOLINO UNA SERIE DI PENSIERI O DI IMMAGINI RICCHE DI SUGGESTIONI.
Il limite che ricordavo all’inizio come elemento indispensabile collegato alla morte diventa allora un dispositivo della mente che, evitando le false certezze e le false assolutizzazioni, permette l’apertura di senso su di un tema così esplosivo che merita di essere contenuto in un discorso ricco di imprevisti e di possibili spunti creativi.
BIBLIOGRAFIA
Berger Peter L., Il brusio degli angeli: Il sacro nella società contemporanea Mulino, Firenze 1999
Di Nola A., “Sciamanesimo”, in Enciclopedia delle religioni, 5, Firenze, 1973, pp. 857-904.
Fornari F., Psicoanalisi e cultura di pace: antologia di scritti sulla guerra e la pace, Firenze, Edizioni Cultura della Pace, 1992.
Freud A., L’io e i meccanismi di difesa, Giunti, Firenze 1995
Palo G., Sociologia Della Conoscenza E Etica, XX(1979) Rivista Di Teologia Morale, EDB, Bologna.
Palo G., La stagione degli addii, Rito mito morte, Alice, Lugano 1989
Palo G.,, La Comunicazione Nel Mondo Contemporaneo, VIII(1999)2 Bioetica e Cultura, Ist.Siciliano Di Bioetica, Palermo.