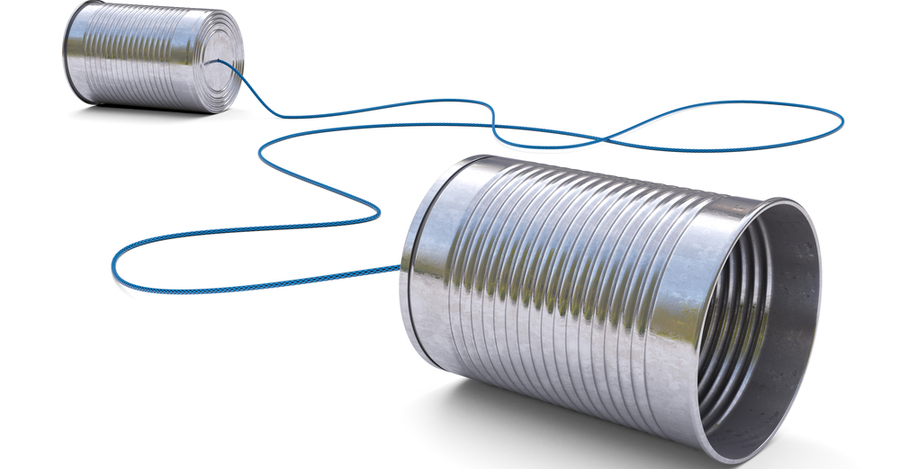Non è stato facile scrivere a quattro mani…
Le mie emozione di “donna” amica, collega, “allieva” di M. Luisa Algini, prendevano un posto forte ed ingombrante sui miei pensieri.
Pensare con Gianangelo come impostare il lavoro di recensione ci ha, anche questa volta, fatto sentire la grande differenza fra il suo “pensare maschile”: sintetico, essenziale e il mio “pensare femminile”: analitico e dettagliato.
Il tema del libro: la morte e il lutto vissuto dal bambino e dai genitori (il genitore vivo e il genitore che muore) hanno aumentato il carico emotivo.
Leggendo questo testo ricco di spunti creativi, ci soffermiamo su alcuni elementi che ci sembrano significativi per noi che leggiamo e, pensiamo anche per coloro che vorranno personalmente affrontare questo scritto.
M. Luisa Algini, già nota al pubblico psicologico per le sue numerose pubblicazioni apparse in vari contesti, soprattutto in “Quaderni di Psicoterapia Infantile” (ed. Borla), ci conduce in un cammino che vuole essere una competenza rigorosa anche teorica e una dimensione quasi poetica che avvolge tutto lo scritto.
Direi che quello che emerge maggiormente è la capacità narrativa che diventa lirica e prende il lettore quasi avvolto da questa dimensione.
L’immagine di copertina si presta a ulteriormente evidenziare questo aspetto.
La Ferita del grande albero si affianca al buco enorme che l’accompagna. In questa immagine c’è tutto quello che abbiamo espresso prima.
Ferita, richiama la ferita narcisistica e tutto quello che l’accompagna. Ma ferita si coniuga anche con il “buco”, il vuoto che l’affianca. Il vuoto che può essere riempito e trasformato in un nido, il nido del rapporto terapeutico che Algini sa costruire e descrivere in modo eccellente e, a volte, struggente. Un nido che non è sempre ovattato, che, a volte, fa emergere le sue spine, ma un nido che richiama la cicatrice. Cicatrice che è possibile curare se si uniscono le parti lacerate, se il vuoto viene riempito da una operazione di cucitura, di legame in cui i fili vengono sapientemente tirati.
Ecco allora il grande discorso del Transfert nei suoi complessi elementi teorici che però vengono ben evidenziati dalla narrazione quasi poetica.
A un certo punto compare una figura importante, Dina Vallino che noi sentiamo un po’ come Virgilio nel viaggio dantesco. Dina non è una spalla a cui appoggiarsi passivamente, ma una spalla che sprigiona energie interpretative e calore necessario per affrontare situazioni non facili. Diventa un aiuto nella costruzione del nido che fa entrare in gioco varie figure: il bambino, la terapeuta.
Il cuore del libro, ci dice M. L. Algini, è costituito da quattro storie cliniche narrate attraverso una “finzione descrittiva”. L’autrice cerca di immaginare come i bambini potrebbero raccontare la propria storia, così come è nata e si è sviluppata nell’hic et nunc della relazione analitica.
Nel Viaggio incontriamo:
- Kiriku: un bimbo piccolo di soli quattro anni, un bimbo “speciale”, che insegue il “segreto” delle sue origini con un intreccio di emozioni esplosive, turbolente e nello stesso tempo molto tenere. Le storie sono caotiche, ingarbugliate, ma Kikki (la sua terapeuta) le accoglie e piano piano il gomitolo spinoso si dipana. Kikki, con delicatezza e grande competenza terapeutica, aiuta Kiriku e la sua mamma a dare valore e parola ai ricordi e a raggiungere il doloroso “segreto”. “Si può camminare insieme con le tasche piene di sassi” (come dice la canzone di Jovanotti).
- Joker: un bambino di nove anni a cui è morto il babbo il giorno di Natale quando aveva cinque anni. “Il mio problema sono le emozioni, vorrei essere senza emozioni, questa sarebbe la vera felicità. Maledetti sentimenti”…”E’ morto mio padre e voglio morire anch’io”. Joker si interroga: “Perché papà è morto? Dove è ora? Dove vanno i morti? Cos’è un cimitero?” “Mamma non mi ha mai portato a vedere quella tomba”. Capita spesso che con un bimbo a cui muore un genitore si adotti la negazione, come se nulla fosse accaduto (questo a maggior ragione quando il bimbo è piccolo). Per la mamma di Joker la morte e il dolore per la morte vanno tenuti lontani, dimenticati, “il trauma della morte del marito cancellato, respinto fuori dalla memoria”. Per tutti, e a maggior ragione per un bambino, è importante avere un luogo, uno spazio nella mente dove collocare la persona amata che ci ha lasciato per sempre. La tomba assume il significato di “uno scoglio su cui l’onda di dolore può frangersi in un va e vieni, che permette di girare intorno a quello che si sente”. Spesso si pensa che sia utile “non parlare” per “non far vedere” quando si è sconvolti e provocare in questo modo ulteriore sofferenza. “E’ un’idea che si regge sull’illusione che, evitando le parole, i bambini possano non accorgersi di quanto sta male il genitore” scrive Maria Luisa Algini. Per la mamma di Joker è quasi impossibile “aprirsi alla parola” per condividere.
- Zeta: È la storia più drammatica, “al limite della pensabilità”. Significativa è la scelta del nome dato alla giovane paziente: Zeta, l’ultima lettera dell’alfabeto. La vita di questa ragazzina è rimasta appesa ad un filo, trascinata dal folle gesto della madre, che suicidandosi la porta con sé. Il corpo mutilato e la mente mutilata. L’angoscia di ricordare il trauma, anche se il moncone del braccio è lì sempre presente a testimoniare la Ferita e l’evento traumatico. Maria Luisa nel testo scrive: “Il non ricordare ci aiuta…Per ricordare cose dolorose occorre molto tempo, bisogna allontanarsi dai fatti, guardare lontano con calma insieme a qualcuno che ci aiuti a sentirci meno spaventati”. Zeta “doveva essere riconosciuta come bambina, sentire che esisteva un’analista che la guardava e con cui poteva ripristinare qualcosa della propria vita, anche l’importante funzione mentale, simbolica e dialogica” suggeriscono nel testo le parole di Dina Vallino. La psicoterapia per Zeta è la speranza di sentire le braccia forti della sua terapeuta che la sostengano.
- Marta, la piccola paziente di Dina Vallino, che “faceva finta di niente”. “Si può evocare la morte della madre se la bambina fa finta di niente e parla d’altro?” si chiede Dina. Capii che bisognava uscire dall’anestesia, perché il suo dolore non era ‘terminale’, ma espressione di vita mentale”….”La vita è circolazione di affetti, anche di affetti dolorosi come la mancanza, la nostalgia, il rimpianto, la solitudine”.
- Giovanni Segantini. In una lettera scrive al suo interlocutore: “Lei mi chiede come, nella vita quasi selvaggia in mezzo alla Natura, mi sia venuto sviluppando il pensiero e il sentimento dell’Arte?….non saprei…forse per spiegarlo bisognerebbe scendere fino alle radici: studiare, analizzare tutte le sensazioni dell’anima fino alle prime emozioni, anche le più lontane dell’infanzia”. L’evento cardine dell’infanzia di Segantini: la morte della madre quando non aveva ancora cinque anni, scriverà dodici anni dopo la morte del pittore della natura il grande psicoanalista Karl Abraham. L’arte per Segantini è “il canale che permette rappresentazioni all’amore e al dolore”.